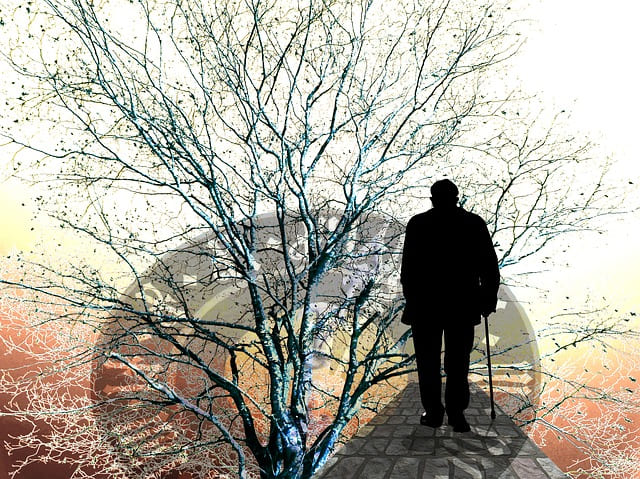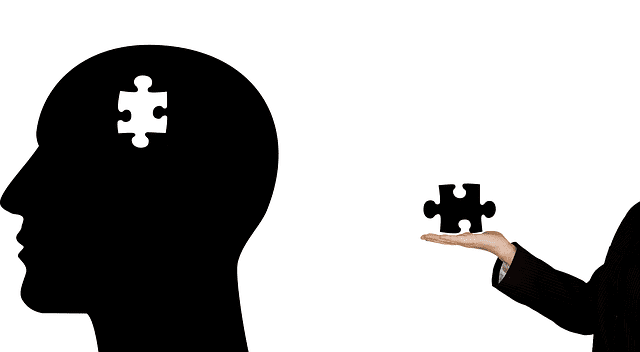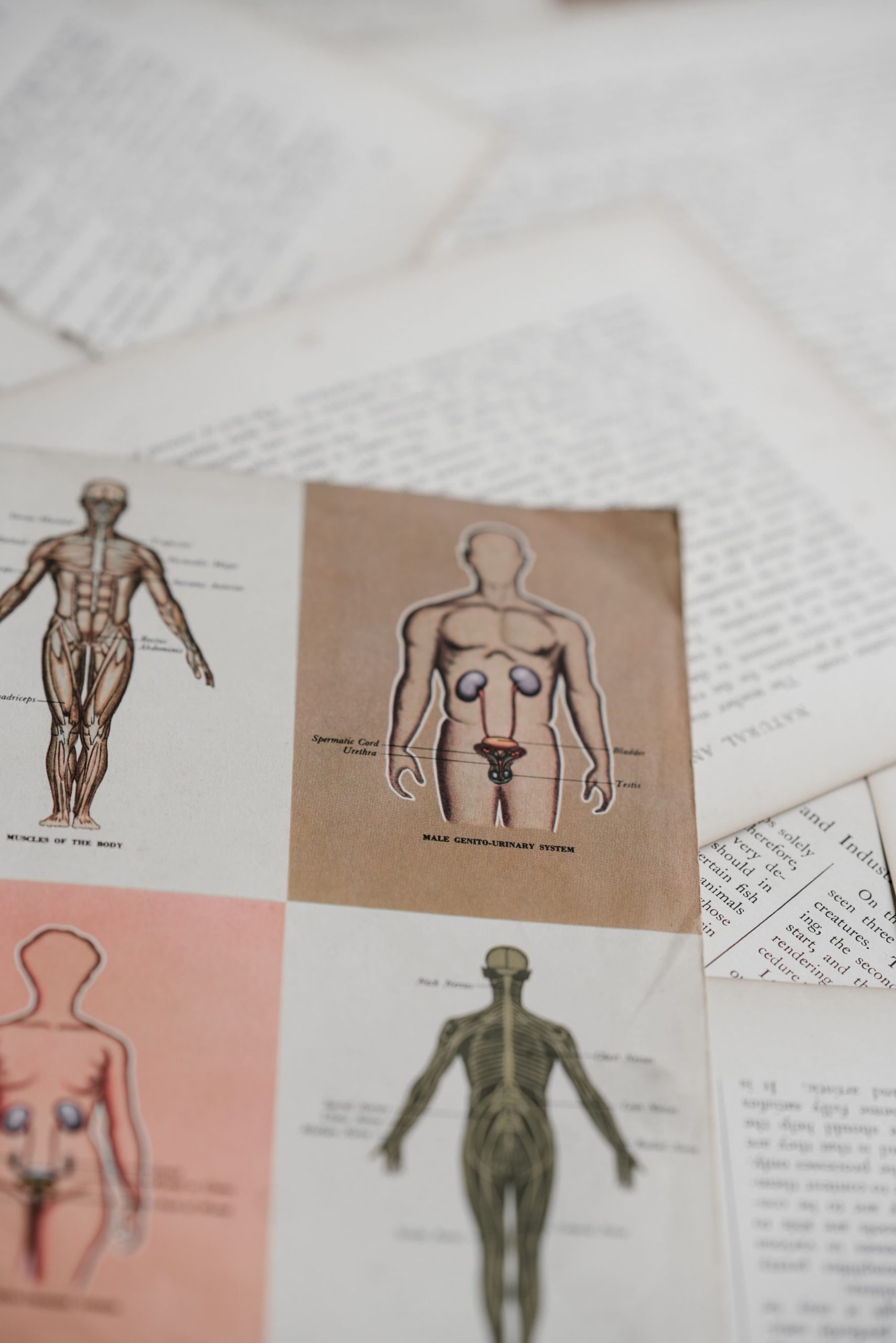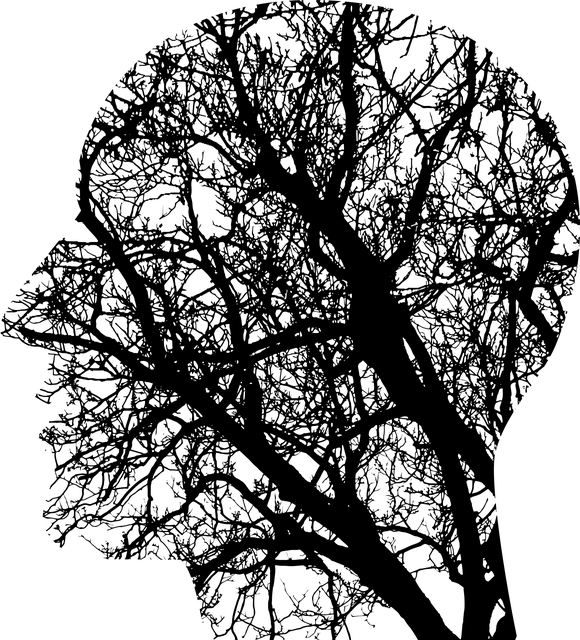Rifiuto cure da parte dell’Amministratore di sostegno: ci vuole un potere ad hoc
La Corte Costituzionale si pronuncia sul tema del rifiuto cure da parte dell’amministratore di sostegno e circoscrive il perimetro dei poteri che gli sono attribuiti dalla legge
Ringraziamo la Collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.
Come è noto, la recente legge n. 217/2019 – cd testamento biologico – statuendo che ” nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge“, ha riconosciuto la possibilità per “ogni persona capace di agire” di rifiutare, in tutto o in parte .. qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso“.
In buona sostanza, è possibile rifiutare le cure, anche se siano essenziali per la propria sopravvivenza, purchè tale determinazione sia frutto di una libera e consapevole scelta del disponente, maggiorenne, capace di agire, di intendere e di volere.
E chi non sia più pienamente capace?
Se in passato abbia manifestato con le D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento) le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, queste determinazioni andranno rispettate ed il medico sarà vincolate ad esse, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Per chi non avesse disposto D.A.T., la legge ha statuito che il consenso o il rifiuto delle cure sia prestato dal rappresentante della persona incapace: il tutore per l’interdetto, colui che eserciti la responsabilità genitoriale per il minore, l’amministratore di sostegno.
Su tale previsione, tuttavia, si è aperta un’intensa discussione, giuridica e morale.
Rifiuto cure da parte dell’Amministratore di sostegno
Ci si è interrogati se un Amministratore di sostegno, eventualmente investito dal Giudice Tutelare, come spesso avviene, del potere di rappresentanza in materia di prestazione del consenso informato a trattamenti sanitari, potesse spingersi addirittura a rifiutare le cure per il proprio assistito, intervenendo – direttamente o indirettamente – nel percorso clinico e vitale dello stesso.
Il Giudice Tutelare di Pavia ha investito della problematica la Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità della suddetta legge nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
Nella fattispecie, all’amministratore di sostegno, già nominato circa una decina di anni prima, non era stata attribuita alcuna rappresentanza in ambito sanitario.
Dal momento che il beneficiario si era venuto a trovare successivamente in stato vegetativo, il tribunale di Pavia aveva ritenuto necessario integrare il decreto di nomina, prevedendo anche poteri in ambito sanitario.
Tuttavia, secondo il giudice tutelare, la norma di cui all’art. 3 della legge n. 219/2017, quando stabilisce che l’amministratore di sostegno con potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, verrebbe a violare gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione.
In particolare, secondo il Giudice Tutelare, una tale ampia e generica attribuzione di poteri verrebbe ad attribuire all’ADS sostanzialmente “il potere di decidere della vita e della morte dell’amministrato”, senza alcun sindacato da parte dell’autorità giudiziaria.
Il rifiuto delle cure deve corrispondere alla volontà dell’interessato e dei suoi orientamenti esistenziali: l’amministratore non deve decidere né al posto dell’incapace, né per l’incapace, perché rifiutare le cure è un diritto personalissimo.
Quindi, o la decisione sul rifiuto delle cure risulti dalle DAT o, in mancanza, dovrà essere ricostruita la volontà dell’incapace, mediante indici sintomatici, di elementi presuntivi, o con l’audizione di conoscenti dell’interessato o strumenti di altra natura.
Secondo la Corte Costituzionale si tratta di un presupposto interpretativo erroneo.
Come abbiamo avuto già modo di affermare, (post) l’amministrazione di sostegno è un istituto “duttile, suscettibile di essere plasmato dal giudice sulla necessità del beneficiario” ed avente ad oggetto “le sole categorie di atti al cui compimento l’amministratore sia ritenuto idoneo”.
Del resto l’amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, si propone di “limitare nella minore misura possibile la capacità di agire della persona”.
Alla luce di tali precisazioni, si può affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.
Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno, è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.
Spetta al giudice, quindi, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017.

Le misure di tutela, quindi, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque, alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il giudice tutelare affidare all’amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa.
La specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione all’amministratore di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sanitari di sostegno vitale: in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su “diritti soggettivi personalissimi”, sicché la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute della persona con disabilità in quel dato momento considerato.
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile.
L’adattamento dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del beneficiario.
La Corte Costituzionale conclude arrivando a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.
Le norme censurate, infatti, si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 13.06.2019

Per scaricare GRATUITAMENTE
la GUIDA ALL’INGRESSO IN CASA DI RIPOSO
Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di
rifiuto cure da parte dell’amministratore di sostegno